Parole chiave: Milano
Storia della Bocconi
1902-1915. Gli esordi
La «Perseveranza», il «Corriere della sera», la «Lombardia», la «Lega lombarda», la «Sera», il «Sole», il «Commercio»: la rassegna delle testate cittadine non può tuttavia andar oltre. Il «Secolo», l’«Italia del popolo», la «Lotta di classe», l’«Osservatore cattolico», la «Critica sociale» in quelle settimane non uscivano: e ne sono ben noti i motivi. Se la decisione di onorare il figlio con un lascito cospicuo fu presa da Bocconi nel marzo 1898, in occasione del secondo anniversario della sua scomparsa, prima dunque delle tragiche giornate che insanguinarono Milano tra il 6 e il 9 maggio, l’annuncio del progetto venne dato, come si è appena visto, a poco più d’un mese dai tumulti e dalla sanguinosa repressione che aveva sconvolto e profondamente segnato la città ambrosiana, ponendo a tacere alcuni dei suoi organi di stampa.
Il caso volle, fra l’altro, che proprio in quello stesso 12 giugno in cui pubblicava con gran rilievo su due intere colonne di spalla in prima pagina il testo della lettera di Bocconi e della risposta di Colombo in merito alla nuova istituzione per gli studi commerciali appena decisa, il «Corriere della sera» pubblicasse altresì come editoriale la lettera con la quale il fondatore del giornale, Eugenio Torelli Viollier, dava l’annuncio ufficiale del proprio ritiro dalla direzione (di fatto affidato già da una diecina di giorni all’altrimenti orientato Domenico Oliva). Un ritiro motivato con ragioni di salute, ma che tutti sapevano dovuto ai contrasti ormai insanabili con la proprietà e con la linea al momento prevalente entro lo schieramento moderato milanese. Qualche giorno prima, Torelli Viollier aveva espresso privatamente il suo vero pensiero e fornito la sua ricostruzione dei fatti, denunciando il comportamento delle autorità e della élite cittadina, in una lunga, amarissima e risentita lettera allo storico Pasquale Villari (uno dei collaboratori coi quali avvertiva maggiore consonanza), che in effetti ne era rimasto non poco colpito: «A dire il vero io non credevo che anche a Milano la borghesia si lasciasse prendere dal furore della vendetta fino al punto di voler reprimere non prevenire. Pure è la città più illuminata, che ha il più gran numero di istituzioni benefiche, il più vivo spirito di civile carità»[1].
Tanto più ad un occhio esterno, abituato a considerare in tutt’altra prospettiva il ruolo e la fisionomia del centro ambrosiano nel contesto nazionale, il contrasto era in effetti dei più sorprendenti e clamorosi. All’orgoglio ed alla apparente sicurezza di sé della «capitale morale» (un titolo rivendicato, ma anche largamente riconosciuto ed ammesso dagli osservatori esterni a fronte dei risultati raggiunti) faceva ora riscontro ben altro quadro, ben altra immagine. Quella di una città in cui la tradizionale classe dirigente sembrava aver perduto il controllo della situazione, avvilita da un regime d’assedio che si prolungava oltre ogni ragionevole giustificazione, in cui i tribunali militari, a completamento e a legittimazione del comportamento repressivo e dei suoi eccessi, comminavano agli arrestati valanghe di condanne: 6 anni al repubblicano Gustavo Chiesi, 4 anni e 2 mesi al radicale Carlo Romussi, 2 anni ad Anna Kuliscioff, 3 anni al direttore dell’«Osservatore cattolico» Davide Albertario, 1 anno e 6 mesi a Paolo Valera, addirittura 12 anni a Filippo Turati e al repubblicano Luigi De Andreis – per non citare che alcuni dei «politici» sottoposti, contro ogni evidenza giuridica e testimoniale, a quel trattamento.
Avvalendosi delle circostanze eccezionali in cui era venuta a trovarsi, della sospensione forzata, che proseguiva, dei giornali d’opposizione, dell’arresto o della fuga di molti esponenti socialisti e repubblicani, dell’opera intimidatoria esercitata dai tribunali militari, la Milano moderata (o almeno una sua parte rilevante) cercava in effetti di giocare a quel punto il tutto per tutto, al fine di ristabilire, una volta per sempre, le debite distanze e i giusti ruoli. Il ridimensionamento, che si intendeva a ogni costo produrre, non riguardava solo la Milano socialista o quella repubblicana, più facilmente confondibili da occhi conservatori con il retroterra anarchico o genericamente ribellistico indubbiamente presente in città e da cui potevano essere effettivamente emerse nel corso di quelle drammatiche giornate spinte e suggestioni conseguenti[2]. Erano coinvolte nella medesima visione e nella medesima prospettiva anche la Milano più genericamente democratica e radicale e parte di quella cattolica, messe tutte, a diverso titolo, sotto accusa e indicate come parimenti responsabili di quanto era accaduto. I moti di maggio non erano da interpretarsi, insomma, come un episodio occasionale e imprevedibile. Essi erano, al contrario, il frutto avvelenato d’una più lunga azione preparatoria ovvero, e nel medesimo tempo, il portato di fattori degenerativi operanti da lunga pezza nel sistema politico e nel tessuto sociale e civile del paese, da trattare dunque come tali, senza incertezze o ulteriori tentennamenti.
Frutto, sugli opposti fronti, dell’esasperazione e della paura, di rancori a lungo alimentati e di radicate prevenzioni, di comportamenti malaccorti e di calcolate strumentalizzazioni, i fatti di maggio avrebbero inciso in profondità sulla vita cittadina, sulla fisionomia delle forze politiche, sugli equilibri interni alla classe dirigente, sulle scelte e sulle strategie dei gruppi d’opposizione, accelerando e consolidando processi già in atto e innescandone di nuovi, sullo sfondo di una più generale crisi di trapasso a livello nazionale, non a caso imperniata sul nodo drammaticamente emerso e emblematicamente espresso proprio dalle vicende milanesi: la conciliabilità, cioè in una società a crescente partecipazione popolare e soggetta a processi accelerati di modernizzazione, delle esigenze d’ordine e di regolata convivenza con le istanze di libera organizzazione politica e con il loro esercizio anche da parte di forze che, almeno parzialmente e in linea di principio, non si riconoscevano nel sistema istituzionale o sociale esistente[3].
Dal punto di vista degli equilibri e dei rapporti di forza a livello cittadino, la riacquisizione da parte dei moderati della tradizionale posizione egemonica (d’altronde confermata alle elezioni amministrative del 1895 solo grazie al decisivo contributo elettorale dei cattolici)[4] sarebbe dipesa sempre più dai possibili effetti di interventi di portata più generale legati alle scelte governative e alla costituzione a livello nazionale di una omogenea maggioranza conservatrice entro cui far valere le proprie istanze. Dopo il ritiro di Di Rudinì e la mancata assegnazione della successione a Visconti Venosta, la speranza che a tanto si potesse finalmente arrivare si riaffacciò alcuni mesi più tardi, nel febbraio 1899, quando il presidente del Consiglio Pelloux si mise a sua volta sulla strada tentata otto mesi prima dal predecessore presentando alla Camera un suo pacchetto di provvedimenti politici diretti a ridurre e a condizionare la libertà d’associazione e di stampa. Un ulteriore passaggio intervenne qualche settimana più tardi, a metà maggio. Un malaccorto tentativo del governo italiano di ottenere una concessione nei lontani mari della Cina si era risolto in un nuovo smacco sulla scena internazionale, che venne fatto ricadere sull’inesperienza e l’effettiva inabilità dell’allora ministro degli Esteri Canevaro. Le dimissioni dell’intero governo e il successivo rimpasto aprivano la strada al ritorno alla Consulta di Emilio Visconti Venosta: una scelta funzionale a rimettere sulla giusta rotta la barca della politica estera italiana, ma che assumeva una parallela e non meno significativa valenza dal punto di vista della politica interna e degli equilibri tra i vari gruppi costituzionali, accompagnata com’era dal distacco dalla maggioranza e dal passaggio all’opposizione di Zanardelli e di Giolitti, sin lì principali ostacoli al disegno conservatore coltivato dai milanesi. S’aggiunga che un altro elemento di primo piano della consorteria moderata lombarda, Pietro Carmine, assumeva nella compagine in questione il dicastero delle Finanze. A poco più d’un anno dai tumulti di Milano, poteva dunque sembrare giunto a compimento il disegno a lungo vagheggiato di affidarsi a «uomini d’ordine» sicuri e all’altezza delle esigenze, in grado di comprendere «tutte le necessità della tutela sociale», capaci di «amministrare», potendo contare su «una maggioranza omogenea, compatta, fedele, un vero e proprio partito che possa sostenere la grande opera di riforma e di restaurazione»[5]. Tale era stata non a caso la richiesta adombrata come espressione di un più ampio schieramento locale da De Angeli sin dalla metà di maggio dell’anno prima, a favore appunto di «un governo veramente forte colla concentrazione di tutti i migliori elementi conservatori, per condurre in porto provvedimenti molto energici, che, senza essere reazionari, siano adeguati alla grave situazione»[6]. Inattuato allora, il disegno a quel punto si riproponeva: ma era da vedere con quali risultati.
Intanto, a Milano, alle elezioni amministrative parziali del giugno 1899, la vittoria arrideva netta e senza equivoci, ai partiti popolari. L’alleanza tra socialisti, radicali e repubblicani si era già costituita qualche settimana prima, in marzo, e con esiti trionfali, intorno alla candidatura di Turati (dichiarato decaduto il mese prima da deputato in quanto condannato) al V Collegio cittadino. La stampa moderata aveva in parte giustificato l’episodio facendo presenti le particolarità delle circostanze (Turati era ancora incarcerato) e la specifica configurazione sociale del suburbio, dov’era presente una nutrita area operaia di recente immigrazione, facile preda come tale della propaganda socialista[7]. In vista delle elezioni amministrative parziali di giugno si tentò in effetti di far leva sul radicalismo più temperato nonché sul ceto commerciale, ritenuto il più sensibile a certi argomenti, agitando lo spettro, in caso di vittoria avversaria, della prossima inevitabile trasformazione del municipio in senso «nettamente socialista»[8], e dell’irreparabile salto nel buio che ne sarebbe seguito: «Ogni regolare procedimento civico verrebbe (…) inevitabilmente sconvolto; nessuna istituzione rimarrebbe salva (…); l’istruzione non sarebbe retta da alti e larghi criteri, ma aggiogata a quella squisita tolleranza massonica che vuol cacciato dalle scuole l’insegnamento religioso; la finanza sconvolta da cima a fondo, (…) schiava di municipalizzazioni esagerate o coatte»; lacerata «l’armonia tra l’Autorità cittadina e l’Autorità politica»[9].
Ma non era agevole contrastare una propaganda emotivamente efficace come quella democratica, imperniata sugli eventi, tutt’altro che dimenticati in città, dell’anno precedente e sulla rinnovata denuncia delle relative responsabilità. Una sommossa, «non molto più grave delle dimostrazioni ch’erano avvenute altre volte» – ricordava una volta di più il «Secolo» –, «un aborto di sollevazione che poteva essere finito con poche pompe d’acqua o con una ventina di arresti», era stato affrontato in modo tale da trasformare Milano in «un campo di battaglia, dove di armati vi erano solamente i soldati» e dove si era fatto strage di innocenti «come nei tempi della più efferata tirannide»: e questo perché in «certe sfere ufficiali» si era coltivata la convinzione che una «buona cavata di sangue» avrebbe ridotta la città «a sentimenti di assoluta sottomissione». Memore delle «carrate degli uccisi, condotti di notte al cimitero di Musocco», Milano avrebbe però mostrato a chiare lettere, col suo voto, in che concetto tenesse «i suoi pretesi medici colla loro sanguinaria medicina»[10]. Creare le condizioni per una cacciata della vecchia oligarchia moderata da palazzo Marino rappresentava d’altra parte solo una premessa. I partiti popolari si proponevano per la successione forti comunque di un programma «pratico di amministrazione» coerente e praticabile, offrendo con ciò stesso l’indicazione di un modello e l’ennesima sanzione del particolare ruolo della città: «città nazionale per eccellenza», come la definiva Guglielmo Ferrero, destinata a svolgere in Italia il medesimo ruolo di Parigi in Francia, a godere cioè e ad assumersi i «privilegi e (…) le gravi responsabilità storiche della città politica»[11].
In simile ottica e in simile prospettiva la stessa faida locale assumeva ben altro rilievo; diventava (era sempre Ferrero a sostenerlo, collaboratore fisso del quotidiano di Sonzogno dall’ottobre 1897[12] ed uso a impostare i suoi commenti a larghe visioni d’insieme dei processi in atto nelle società contemporanee) «una battaglia singola della gran guerra politica, che imperversa su tutta la penisola»[13]. L’Italia (era stato ancora Ferrero a introdurre alcuni mesi prima in siffatti termini il tema) era un poco simile ad un esercito sbarcato in un paese nuovo per conquistarlo, ma senza aver bene valutato le difficoltà dell’impresa: dove il «paese nuovo era la civiltà moderna». La compagine in questione si trovava al momento «in condizioni gravi»: «la sua composizione è difettosa, la conoscenza del paese manchevole, i capi inetti, i soldati scontenti o poco fiduciosi». Ma sarebbe stato vano pensare di farla ritornare indietro: «allo sbarco furon bruciate le navi»[14]. Fuor di metafora: il tentativo conservatore di «mummificar l’Italia nel suo stato presente»[15], di intimidirla annullando ogni forma di opposizione, andava ad ogni costo battuto. E tale era appunto il significato di fondo, per l’intero paese, delle elezioni amministrative parziali milanesi:
Si vedono in Italia i primi segni fausti di una rinascenza economica, intellettuale, politica; forze nuove e giovani crescono, si esercitano a fare e preparano, nel silenzio, un’Italia nuova e migliore della presente. Guai se l’oligarchia che governa potesse disturbare questa delicata elaborazione vitale con le violenze di una politica reazionaria o con le follie di una finanza dissipatrice! Milano deve mostrare che essa, dall’alto dell’Italia, vigila, sentinella fedele della libertà, guardiana coraggiosa dei tesori più preziosi della rivoluzione: la sua fama di città devota alla libertà deve proteggere in tutta Italia quanti lavorano a diffondere, anche lontano da lei, uno spirito nuovo di civiltà[16].
Una volta ancora Milano diventava insomma l’epicentro d’uno scontro di portata decisiva: a conferma della sua capacità già rilevata di «dare un significato e un’anima nazionale anche agli affari suoi municipali», di interpretare più di tutti gli altri centri della penisola il grande e diffuso «malumore», il «malcontento vago e impalpabile» che si respirava in Italia da almeno un decennio, e esploso anche clamorosamente in più occasioni, a indicazione di una situazione di crisi, forse tuttavia meno lontana da sbocchi positivi di quanto a prima vista non si potesse ritenere: «tutto sembra segno di male e rovina; mentre molte cose chiudono invece in sé un presagio di bene futuro»[17]. Milano «capitale morale»: il soprannome già accettato senza discussioni e che gli avversari avevano cercato di trasformare in epiteto derisorio, tornava insomma a venir rivendicato nella pienezza del suo significato, associato al ruolo che la democrazia si apprestava ad assumervi. Glielo riconosceva anche un altro osservatore esterno, come il repubblicano Napoleone Colajanni: «perché essa sola in Italia è un vero centro di vita politica, in cui si forma ed esercita la sua azione una corrente della pubblica opinione, altrove deficiente o nulla addirittura»[18].
All’indomani della sconfitta, la «Perseveranza» ammise che, per quanto prevedibile «da chi rifletteva al rapido ingrossarsi delle liste elettorali», questa aveva «superato le più nere aspettazioni»[19]. I moderati erano stati ulteriormente indeboliti dal comportamento, tra i cattolici, dell’ala intransigente, che pur senza riuscire a far passare nessuna delle proprie candidature specifiche, aveva avuto un ruolo determinante nella designazione degli otto eletti della minoranza (tra cui cinque cattolici) e nel far mancare i suffragi necessari alla rielezione di Gaetano Negri, cioè della figura a vario titolo più rappresentativa tra quelle proposte dalla consorteria moderata. Un effetto della «cieca e sfrenata signoria del numero» associata all’«odio», all’«invidia», ad un «implacabile spirito di vendetta», commentò scorata di nuovo la «Perseveranza», preannunciando un avvenire «di infeconde agitazioni, di lotte accanite, di confusione e di disordine»[20]. «Le schede hanno stimmatizzato l’opera del cannone»: era la ben diversa ed entusiasta reazione del «Secolo»[21], che già pregustava il piacere di ulteriori, analoghi, prossimi successi della democrazia radicale e dei suoi alleati, socialisti e repubblicani. Successi che in effetti non sarebbero tardati: con l’ulteriore complicanza, dal punto di vista dei moderati, rappresentata sul piano politico generale dall’ormai esplicita definizione d’un organico polo liberale raccolto intorno a Zanardelli e a Giolitti, al quale ultimo mostravano di guardare con attenzione, come ad un interlocutore attendibile, che aveva finalmente capito i veri termini della situazione italiana, anche i socialisti turatiani. In assonanza con simili posizioni, sul «Secolo» Guglielmo Ferrero individuava dal canto suo nel duello in atto tra «libertà» e «reazione» l’esplicitarsi di un altro e non meno sostanziale tipo di scontro «tra le forze della società nostra che voglion rompere gli impedimenti a una maggiore produzione e quelle che voglion invece mantenerli»[22].
Più che mai il moderatismo milanese era posto insomma di fronte ad ipotesi di evoluzione a breve termine contrassegnate comunque da ostracismi nei suoi confronti. E se lo scontro a livello nazionale non si era ancora risolto (in attesa dell’ulteriore passaggio-chiave rappresentato dall’assassinio di Umberto I e dall’avvento del nuovo sovrano, interessato a favorire un’evoluzione in senso liberale della crisi politica italiana), sul piano locale l’appuntamento definitivo si avvicinava.
Reso impossibile il funzionamento di una nuova giunta a palazzo Marino dopo le elezioni parziali di giugno, i milanesi furono chiamati in dicembre a rinnovare l’intero consiglio comunale. Come previsto, l’alleanza dei partiti popolari venne confermata, con la variante rappresentata dalla decisione dei socialisti e dei radicali di non entrare in giunta in caso di successo, lasciando tutt’intera alla democrazia radicale la responsabilità diretta della futura amministrazione. Un esperimento – spiegò il «Secolo» – ch’era nell’interesse di tutti far riuscire al meglio, «perché allorquando i radicali avranno dimostrato coi fatti di saper provvidamente reggere un importante Comune – gli italiani domanderanno a loro stessi se non sia venuto il tempo di affidare ai radicali anche il governo del Paese»[23]. Dal punto di vista più specifico della storia cittadina, le elezioni venivano invece presentate da Romussi (che un indulto aveva nel frattempo rimesso in libertà) come l’ultimo e definitivo passaggio d’una lotta «impegnata da secoli (…) fra l’oligarchia e la parte popolare», in cui quest’ultima, dopo i tentativi andati a vuoto o frustrati dal ricorso avversario a tutti i mezzi per impedirglielo, avrebbe finalmente ottenuto una volta per sempre la sua rivincita, trasformando Milano in «un comune aperto a tutte le attività, a tutte le intelligenze, a tutti i progressi»[24].
Nella lista predisposta dal Comitato liberale presieduto da Giuseppe Colombo era in realtà riscontrabile uno sforzo effettivo di rinnovamento. La stessa difesa di quanto realizzato in passato non si spingeva oltre un certo limite. A «molte utili innovazioni» si era dato mano, grazie alle quali Milano era diventata «una delle città che meglio riflettono l’odierna civiltà». Ma «con ponderato ardimento» altri passi andavano indubbiamente fatti «sulla via del progresso». Nei riguardi dell’edilizia, dell’igiene, dell’assistenza pubblica, dell’istruzione, l’impegno era ad avanzare «in modo deciso», dando la precedenza ai provvedimenti più direttamente rivolti «a migliorare le condizioni delle classi meno fortunate». Doveva nel contempo restare un punto fermo non trascurare «gli studi superiori e le arti», essenziali per un «centro intellettuale, quale, per le naturali tendenze degli abitanti e per lunga tradizione», era Milano[25]. Non risultava meno significativo l’inserimento nella lista, accanto agli esponenti del più tradizionale ceto aristocratico e possidente, di numerosi elementi rappresentativi dell’industria, del professionismo, dell’alta cultura, del commercio, della competenza tecnica. Era, tra l’altro, particolarmente nutrita la presenza di insegnanti del Politecnico e della Scuola superiore di Agricoltura (con nomi di primo piano, come quelli di Vittorio Alpe, Giovanni Celoria, Antonio Jorini, Giuseppe Ponzio, Cesare Saldini – era compreso nella lista anche il futuro rettore del Politecnico dei tempi fascisti Gaetano Fantoli). Un insieme di nomi che si poteva a buon diritto considerare espressione di «quella Milano che lungi dal restringersi ai piccoli orizzonti d’un tempo, [aveva] saputo spinger lo sguardo a tutto il movimento della vita europea» e che, «impadronendosi di ciò che facevano gli altri e adattandolo all’indole italiana e in molti punti segnando anche un notevole progresso sull’opera straniera, [era] diventata una città rispettata e invidiata, centro di coltura, emporio di ricchezza, fucina ardente d’idee e d’iniziative»[26]. Anche su questo terreno non si accettavano insomma lezioni dagli avversari: «Di fronte ai 14 avvocati della lista radico-socialista, noi non ne portiamo che sette»[27].
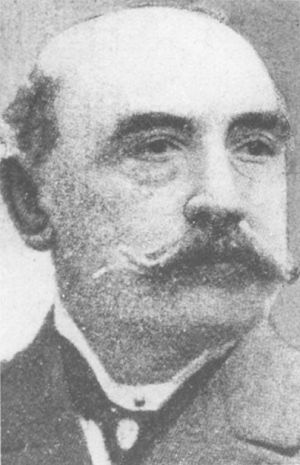 |
Sull’esito finale dei loro sforzi i moderati erano però i primi a non farsi illusioni. Il mancato rinnovo dell’accordo con i clerico-moderati della «Lega lombarda» stava di per sé ad indicare che ci si batteva solo per i posti riservati alla minoranza, e che l’unico obiettivo concretamente praticabile era di riuscire nell’intento conquistandoli tutti, a spese dei cattolici, presentatisi autonomamente. Con circa 3 mila voti in più i moderati batterono in effetti i cattolici, ma furono superati di oltre diecimila suffragi dai primi eletti dei partiti popolari (l’ingegner Angelo Salmoiraghi e il futuro sindaco Giuseppe Mussi in testa). A consolazione si fece notare che la vittoria era in realtà arrisa ad una coalizione nella sostanza ibrida e destinata in un prossimo futuro a scomporsi sotto il peso della concorrenzialità interna e delle oggettive e sostanziali differenze sul piano dei principi e degli obiettivi. La sconfitta era insomma da considerarsi solo apparente, o quanto meno transitoria. L’essenziale era stato salvato: «Bisognava che il partito liberale si affermasse come il nucleo a cui verranno in un futuro, che non vediamo molto lontano, quelli che si gettarono al radicalismo in forza di pregiudizi, dei quali si ricrederanno quelli che, fra non molto, comprenderanno come l’alleanza coi rivoluzionari sia veramente un impaccio per la loro libertà e un ostacolo ad ogni progresso reale». E analoga previsione, o, piuttosto, auspicio veniva avanzato a proposito di «quei cattolici che consentono colle nostre idee e che anelano di togliersi a una servitù che li fa cittadini inutili, mentre potrebbero, animati da sentimenti patriottici e veramente liberali, rendere alla patria comune fecondi servigi»[28]. In attesa di siffatti sviluppi (posto naturalmente che fosse veramente quella la direzione di marcia) era però intanto giocoforza digerire l’amaro boccone della perdita del controllo di palazzo Marino. |
|
Alle successive elezioni generali politiche del giugno 1900 tutti e sei i collegi cittadini sarebbero stati conquistati dai candidati dei partiti popolari: il democratico De Cristoforis, i repubblicani De Andreis e Federici, i socialisti Majno, Turati e Ciccotti. Il risultato più rilevante ed emblematico avrebbe riguardato il II Collegio, tradizionale roccaforte moderata e sin lì appannaggio di Giuseppe Colombo, la cui riaffermazione anche in quella circostanza era stata data dai suoi sostenitori per sicura[29]. Presidente della Camera nella fase più acuta dell’ostruzionismo dell’Estrema Sinistra contro i provvedimenti politici voluti da Pelloux, Colombo era stato di recente protagonista in tale veste d’alcune dubbie decisioni e di comportamenti assai contestati rivolti a favorire il varo delle modifiche del regolamento di Montecitorio proposte dal toscano Cambray-Digny in senso vessatorio per la minoranza. Vincitore nel 1895 con oltre 2500 voti rispetto ai meno di 900 messi insieme dal socialista Gnocchi Viani, questa volta Colombo, pur mantenendo nella sostanza il proprio elettorato, veniva battuto dall’avvocato Luigi Majno (un socialista ma con ampie aderenze anche negli ambienti borghesi e professionali cittadini). Presentatosi a Monza, usciva soccombente dalle urne anche un altro uomo-simbolo dello schieramento moderato, l’ex sindaco Vigoni, superato dal radicale Pennati. La lezione inflitta ai «colpevoli» poteva considerarsi insomma completa e il «Secolo» assicurava che si era di fronte alla definitiva chiusura di un ciclo: «La consorteria milanese che, per mantenere la sua supremazia oligarchica, aveva piombato l’Italia intera nei disastri di una reazione senza pari nella storia – è stata punita come meritava»[30].
↑ 1
P. Villari a E. Torelli Viollier, Firenze, 11 giugno 1898, in Archivio Torelli Viollier, presso il dott. Eugenio Magnani Torelli. La lettera di Torelli Viollier a Villari, del 3 giugno 1898 in L. Villari, I fatti di Milano del 1898. La testimonianza di Eugenio Torelli Viollier, «Studi storici», VIII (1967), pp. 539-549.
↑ 2
Cfr. in questo senso le giuste considerazioni di M. Belardinelli, Un esperimento liberaI-conservatore: i governi di Di Rudinì (1896-1898), Roma 1976, p. 349. In generale sui moti a Milano e sulla relativa repressione cfr. U. Levra, Il colpo di stato della borghesia. La crisi politica di fine secolo in Italia 1896-1900, Milano, 1975; A. Canavero, Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900), Milano, 1976. Per un più generale inquadramento e bilancio storiografico cfr. R. Chiarini, La crisi di fine secolo in Italia, «Annali della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Milano», III (1983), pp. 531-582.
↑ 3
Su questo tema e, più in generale, per una ricostruzione nell’ottica accennata, delle vicende di fine secolo, cfr. ora R. Cambria, Alle origini del Ministero Zanardelli-Giolitti. L’ordine e la libertà, «Nuova rivista storica», LXXIII (1989), pp. 67-150; 609-656; LXXIV (1990), pp. 25-100.
↑ 4
Cfr. in proposito F. Fonzi, Crispi e lo «Stato di Milano», Milano 1965, pp. 292 e segg.
↑ 5
«Corriere della sera», 4-5 maggio 1899, La crisi.
↑ 6
L. Luzzatti, Memorie, vol. II (1875-1900), Bologna 1935, pp. 511-512.
↑ 7
Cfr. ad es. «Corriere della sera», 18-19 marzo 1899, L’elezione del V collegio all’Associazione Costituzionale di Milano.
↑ 8
Cfr. ad es. 18-19 maggio 1899, Lotta contro i socialisti. Sulle elezioni parziali del giugno 1899, come, più in generale sulle vicende politico-amministrative milanesi in questa fase cfr. Canavero, Milano e la crisi, cit., pp. 331 e segg. e M. Punzo, Socialisti e radicali a Milano. Cinque anni di amministrazione democratica (1899-1904), Firenze 1979.
↑ 9
«La Perseveranza», 11 giugno 1899, Elezioni amministrative 1899. Basta una scheda!
↑ 10
«Il Secolo», 7-8 giugno 1899, Il punto capitale della questione.
↑ 11
«Il Secolo», 27-28 maggio 1899, G. Ferrero, Roma.
↑ 12
Cfr. L. Barile, Il Secolo 1865-1923. Storia di due generazioni della democrazia lombarda, Milano 1980, p. 255.
↑ 13
«Il Secolo», 2-3 giugno 1899, G. Ferrero, Le elezioni di Milano e l’Italia.
↑ 14
«Il Secolo», 30-31 dicembre 1898, G. Ferrero, Piccola filosofia degli almanacchi.
↑ 15
«Il Secolo», 20-21 gennaio 1899, G. Ferrero, I conservatori.
↑ 16
«Il Secolo», 2-3 giugno 1899, art. cit.
↑ 17
«II Secolo», 10-11 giugno 1899, G. Ferrero, Milano.
↑ 18
«Il Secolo», 11-12 giugno 1899, N. Colajanni, La capitale morale.
↑ 19
«La Perseveranza», 13 giugno 1899, Il risultato delle elezioni.
↑ 20
«La Perseveranza», 13 giugno 1899, art. cit.; 19 giugno 1899, I vinti.
↑ 21
«II Secolo», 12-13 giugno 1899, La splendida vittoria…
↑ 22
«Il Secolo», 20-21 ottobre 1899, G. Ferrero, Libertà e benessere.
↑ 23
«Il Secolo», 6-7 dicembre 1899, Le elezioni di Milano.
↑ 24
«Il Secolo», 9-10 dicembre 1899, C. Romussi, Agli Elettori!
↑ 25
«La Perseveranza», 24 novembre 1899, Elezioni amministrative. Il programma del Comitato liberale.
↑ 26
«Corriere della sera», 9-10 dicembre 1899, d.o. [D. Oliva], Domani.
↑ 27
«La Perseveranza», 4 dicembre 1899, Elezioni amministrative. La nostra lista.
↑ 28
«Corriere della sera», 13-14 dicembre 1899, L’elezioni del 10 dicembre.
↑ 29
Cfr. ad es. «Corriere della sera», 2-3 giugno 1900, La lotta elettorale a Milano.
↑ 30
«Il Secolo», 4-5 giugno 1900, La vittoria di Milano.

-
La prima università commerciale «decoro di Milano e dell'Italia»
-
L'aula e l'ufficio. Il Consiglio Direttivo dell'Università Bocconi al lavoro
-
Gli studenti e la loro università (1902-1914)
