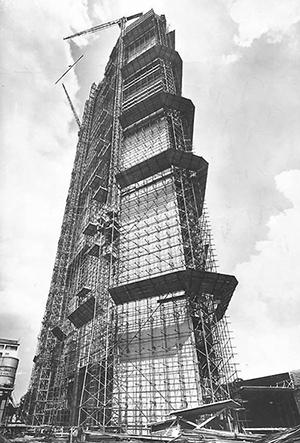Parole chiave: Milano, Rapporti istituzionali
Storia della Bocconi
1968-2022. Dalla contestazione all'internazionalizzazione
Una grande istituzione formativa rispecchia, nella sua evoluzione, sia la storia delle discipline delle quali organizza l’insegnamento sia il rapporto che intrattiene con la società e con il retroterra di comportamenti e culture che le fa da sfondo. Ciò è vero in modo particolare per un’istituzione che appartiene all’alta formazione in campo economico come l’Università Bocconi e che ha sempre coltivato un rapporto particolare non solo con la società italiana, ma con una sua componente specifica che costituisce anche una sorta di avamposto per l’Italia come la Lombardia e il suo capoluogo.
Così, interrogarsi sui cambiamenti che l’Università Bocconi ha conosciuto nell’arco dell’ultimo mezzo secolo equivale a misurarsi sulle trasformazioni che la cultura economica che essa ha elaborato e diffuso ha contribuito ad attuare o di cui la Bocconi è stata parte attiva, interpretando le sollecitazioni che a essa sono giunte e a cui ha corrisposto. Insomma, si può leggere la storia della Bocconi da un lato come il tentativo di rispondere a domande e impulsi che sono maturati in Italia e in Europa e, dall’altro, in maniera crescente, come l’intento di offrire a tali domande e a tali impulsi linee guida, capaci di indicare percorsi di maturazione. Non c’è dubbio, infatti, che nell’idea di formazione professionale e civile messa progressivamente a punto dall’Università e dai suoi organismi vi sia stata l’ambizione di concorrere alla costituzione di una classe dirigente plasmata da un possesso più pieno e sicuro di strumenti di conoscenza analitica adatti ad affrontare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo.
Che l’Università fosse caratterizzata da un’intenzione pedagogica particolare, emerge già da tutta la sua storia sviluppatasi durante i suoi settant’anni precedenti. Ma la svolta che si compie alla fine degli anni Sessanta proietta la Bocconi in una dimensione ben più ampia di quella che fino allora aveva praticato. Non solo perché i numeri dei suoi studenti e l’ampiezza delle sue strutture conoscono una progressione consistente, ma perché l’Università si confronta con una società che scopre di avere ormai confini e riferimenti più vasti del passato. Era come se l’Italia, al termine del decennio Sessanta, si accorgesse di aver realizzato una trasformazione di cui non aveva colto per intero le proporzioni e prendesse atto che la sua complessione si era ingrandita e fortificata. Presa in quest’onda, anche la Bocconi si rendeva conto che occorreva potenziare le proprie dotazioni e, appunto, rinnovare e affinare i propri obiettivi, così da adeguarli a una realtà accresciuta, mutata nelle sue forze ma anche nei suoi caratteri, disposta soprattutto a guardare a se stessa con più consapevolezza delle proprie risorse per investirle in un mondo le cui frontiere si stavano aprendo e dilatando. Si affacciava inoltre un senso d’improvvisa urgenza, come se si avvertisse che il tempo delle soluzioni e delle risposte efficaci era arrivato e che alcuni passaggi erano indifferibili.
Sulla scia del miracolo economico
L’Italia arrivò alla chiusura del decennio Sessanta sotto l’impressione di aver condotto un processo di sviluppo cospicuo, ma che attendeva di essere indirizzato. Era un Paese che era cresciuto tanto sotto l’aspetto economico e sociale quanto sotto quello civile, ma con evidenti disparità e contrasti. Per molti versi, permanevano le questioni civili del passato che non erano state risolte, ma allo stesso tempo si delineavano nuove contraddizioni che interessavano in primo luogo proprio la società settentrionale. Per quanto attiene la struttura economica, in particolare, c’era un elemento che cominciava a prospettarsi, insito nel fatto che il sistema delle imprese aveva corso, e molto, lungo tutto il periodo del «miracolo economico» e ancora oltre, ma in buona sostanza mantenendo l’organizzazione che aveva già dagli anni Trenta. Durante il periodo fra le due guerre, le imprese, soprattutto quelle di maggiore dimensione, si erano rafforzate nelle loro capacità tecnologiche e organizzative, pur entro i limiti ridotti cui le costringeva il mercato interno, ma non avevano perso di vista lo scenario internazionale, anche quando avevano con esso un’interazione ridotta. Poi, nel dopoguerra, avevano colto le possibilità connesse alla dilatazione dei mercati garantita dal nuovo sistema delle alleanze cui aderiva l’Italia e, capitalizzando le loro dotazioni, avevano impresso un’accelerazione impressionante ai loro affari.
Quel successo, per molti aspetti travolgente, si fondava tuttavia su una base organizzativa che era assai tradizionale e che rifletteva l’ordinamento funzionale e gerarchico tipico delle aziende italiane. Nel momento in cui si aprivano alla concorrenza internazionale, traspariva un’esigenza di ammodernamento nella concezione e nella cultura dell’impresa che la Bocconi avrebbe intercettato. Ciò induceva l’Università a esplorare un ampliamento dei propri insegnamenti, al di là degli schemi didattici cui si era fin lì uniformata, in modo da entrare in contatto con questa domanda di rinnovamento culturale e disciplinare. Così, durante gli anni Settanta, la Bocconi sarebbe uscita dallo schema del piano di studi proprio di una facoltà di Economia e commercio per avviare una trasformazione destinata a diventare permanente.
Nel medesimo tempo, non era certo soltanto l’aziendalistica a essere investita da queste tendenze. I laureati più brillanti della metà del decennio Sessanta che avevano scelto gli studi di macroeconomia diventarono a loro volta artefici di quest’azione di rinnovamento, andando a perfezionarsi nelle università inglesi e americane. Ne derivò un effetto insostituibile di apertura: erano infatti i giovani in formazione a praticare sperimentalmente la via dell’internazionalizzazione, giustamente convinti che una strategia di rinnovamento della ricerca in campo macroeconomico richiedesse un lavoro sul campo originale e di prima mano. Cambridge, Oxford e alcune delle grandi università degli Stati Uniti costituivano un terreno privilegiato per il confronto con gli economisti stranieri e con l’apprendimento di tecniche allora d’avanguardia.
Quest’operazione alla distanza rivela un valore che non può essere sottovalutato. Anzitutto perché, come si è detto, maturò anche – sebbene non soltanto – come una spinta dal basso, perciò tanto più efficace nel promuovere comportamenti e attitudini che avevano successo quanto più tendevano a essere imitati e replicati. In secondo luogo, perché i giovani che andavano a proseguire la loro formazione all’estero si candidavano, di fatto, a essere i docenti di punta di domani, quando avrebbero potuto collaborare in prima persona alla definizione dei programmi d’insegnamento. Infine, negli anni del loro apprendistato stringevano legami con i docenti che facevano loro da tutor e con i colleghi d’università che molto spesso avrebbero resistito alla prova del tempo, creando un network di cui l’ateneo si sarebbe avvalso. Volendo, si potrebbe anche aggiungere che tale nuova sensibilità per i curricula internazionali avrebbe avuto altresì l’effetto di infondere alla Bocconi un imprinting un po’ meno conservatore di quello che aveva avuto all’inizio degli anni Sessanta, quando aveva guardato con più di una punta di sospetto al programma economico del primo centro-sinistra e agli esperimenti – peraltro mancati – di programmazione, non celando il proprio scetticismo.
Bastano queste osservazioni per far intendere come il microclima che si respirava, all’interno della Bocconi come pure a Milano e in Italia (sebbene con gradi differenti), virasse all’ottimismo. L’Università si trovava nelle condizioni di sfruttare il lungo accreditamento che aveva realizzato nel passato ed era, di fatto, al centro della realtà italiana che deteneva la posizione più favorevole per prendere il vento della crescita. Milano era più che mai la capitale economica del Paese, anche se il suo vantaggio e il suo distacco dal resto del Nord non erano ancora così consolidati come sarebbero diventati nei decenni seguenti. Quindi, al di là dei consueti travagli politici dell’Italia, non c’era motivo di dubitare che il progresso degli ultimi vent’anni non si sarebbe interrotto e che la Bocconi avesse titolo per rivendicare un ruolo d’artefice.
Tanto più che la dimensione europea stava guadagnando importanza. L’Italia con cui la Bocconi dialogava più da vicino era una nazione intenzionata ad accentuare la sua vocazione europea, che ora non era più una mera petizione di principio. Le nostre imprese maggiori volevano conquistare un respiro continentale: la Pirelli di Leopoldo, imprenditore quarantenne, avrebbe sperimentato la cosiddetta Union, con l’inglese Dunlop. La Fiat aveva progettato, prima di scontrarsi con l’opposizione (che oggi si direbbe «sovranista») del generale de Gaulle, di acquisire la francese Citroën, visto che era già il secondo produttore d’auto sul mercato d’Oltralpe; la Montedison coltivava piani più oscuri, ma anch’essa si considerava in procinto di conseguire dimensioni europee. Come si vede, ce n’era più che a sufficienza per alimentare le aspettative di un’Italia non soltanto pienamente integrata in Europa, ma potenziale portatrice di un ruolo continentale che doveva sicuramente emergere.
Verrebbe da chiedersi perché il cammino virtuoso del nostro Paese diventi più accidentato a partire dal decennio successivo. E soprattutto se le difficoltà dell’integrazione, fino alla crisi recente dei rapporti con l’Unione Europea, sia da ascrivere a quanto è accaduto, grosso modo, negli ultimi quarant’anni o non si siano scontate anche fragilità e debolezze che erano già presenti nel tessuto italiano quando esso pareva ancora robusto e ben temprato. È una domanda che tuttavia conviene lasciare in sospeso, limitandosi a fornire qualche spunto sul percorso durante il quale la marcia della Bocconi ha teso a disgiungersi, in parte, dall’Italia e, in un certo senso, a segnare uno scarto rispetto a certe propensioni del Paese.
La svolta degli anni Ottanta
Al cambio del decennio, si produce una trasformazione profonda non solo dell’assetto della società italiana, ma nel rapporto dell’Italia con l’Europa e con il resto del mondo. Da un lato, si verificano alcuni passaggi che determinano una sorta di riallocazione della nazione nel sistema continentale; dall’altro, in parallelo con i cambiamenti geopolitici ed economici che sfoceranno nel processo universalmente identificato come globalizzazione, il crollo del blocco sovietico avrà l’impatto maggiore, fra gli Stati europei, sulla Germania e sull’Italia.
Sul caso tedesco, da questo punto di vista, si è detto e scritto moltissimo; assai meno su quello italiano. La riunificazione della Germania ha un costo elevatissimo, che è affrontato anche dall’Europa nel suo complesso, ma che induce una straordinaria opportunità per il nuovo Stato. Al contrario, per l’Italia, il nuovo ordine mondiale rappresenta non solo un costo tanto alto quanto imprevisto, ma ha anche in concreto un effetto di declassamento. Il nostro Paese cessa rapidamente di essere quanto era stato nel lungo dopoguerra vissuto all’insegna della guerra fredda, cioè una nazione-cerniera, situata al crocevia del Mediterraneo fra Occidente e Oriente, quindi dotata di una forte valenza strategica e diplomatica. Non esiste a tutt’oggi uno studio che abbia tentato un calcolo di quanto la situazione creatasi alla fine della seconda guerra mondiale abbia contribuito allo sviluppo economico italiano. Ma certo, a un esame di prospettiva, risulta impossibile sottovalutare il vantaggio strategico derivato dall’appartenenza al campo occidentale, che potrebbe essere oggetto di valutazione in tutti gli ambiti – dalle relazioni di mercato al trasferimento tecnologico, dal sistema del credito alla stessa considerazione accordata al Paese in virtù della sua posizione strategica.
Gli ultimi riverberi di tale condizione di vantaggio si consumano all’inizio del decennio Novanta; mentre – non a caso – il sistema politico collassa durante la convulsa stagione di Tangentopoli e l’Italia si confronta con la più grave crisi della sua storia monetaria recente, che mette in luce i problemi connessi all’ingresso, poco più di dieci anni prima, nel Sistema Monetario Europeo (SME). La tendenza al declino italiano, spesso datata agli ultimi anni del Novecento, insieme con l’affievolirsi della spinta alla crescita, non può essere scissa dal declassamento di fatto subìto con la trasformazione dell’ordine mondiale, sebbene consistenti sintomi di deterioramento potessero essere avvertibili fin dal decennio Settanta. Il sofferto itinerario del Paese per recuperare, insieme, il proprio posto nel mondo e una politica di sviluppo in grado di sostituire quella precedente risale ad allora.
Nessun ateneo, probabilmente, come l’«università commerciale» è stato interprete e protagonista del ciclo di cambiamento che ha investito l’Italia di fine secolo. Di sicuro, nessuno come la Bocconi ha svolto la funzione di un laboratorio che ha distillato approcci e policy poi applicati in maniera lineare a se stessa, cercando altresì di convalidarli e di diffonderli in una società peraltro troppo composita, segmentata e ricca di contrasti per accettare compatta una linea d’azione univoca. L’Università si è mossa fondamentalmente lungo i due assi dell’integrazione europea, prima, e della globalizzazione, dopo, nella convinzione che fossero interdipendenti. Con il tempo «internazionalizzazione» è diventata la parola chiave per definire il suo modello universitario. Un modello destinato a trovare la propria sanzione definitiva dopo il 2000, ma che a ben vedere aveva già le proprie radici nel periodo antecedente. D’altronde, l’impostazione europeista era sempre stata considerata pienamente coerente con la sua vocazione globalista.
Più in generale, presso la società italiana, la Bocconi e la sua immagine diventano simbolo di una modernizzazione economica pervasiva. Prima l’Università era stata circondata da un’aura di rispetto e considerazione che le proveniva dall’accreditamento presso la business community milanese e dall’insegnamento di alcune personalità di spicco. Con gli anni Ottanta, la sua immagine tende a popolarizzarsi, nel senso che il riferimento al suo imprinting è stimolato dalla fortuna che i temi economici incontrano presso l’opinione pubblica, in specie quando la Borsa non è più il terreno di gioco esclusivo di pochi operatori selezionati, di grandi banchieri e imprenditori, ma incomincia a catalizzare l’attenzione di una miriade di risparmiatori, attratti dalla possibilità di differenziare i loro investimenti in modo vantaggioso. Così il «bocconiano» entra persino come personaggio fisso del varietà televisivo più trendy del momento – oltre a ispirare il titolo di un thriller pubblicato negli Oscar Mondadori.
Questa fama dipendeva, più che dai meriti intrinseci, ovviamente estranei al grande pubblico, dal fatto che in quel frangente l’Italia economica stava vivendo la sua «estate indiana». Trascorsi i turbolenti e tempestosi anni Settanta, dalla metà del decennio seguente sembrava che il Paese stesse vivendo quasi un secondo miracolo: la Fiat Uno era l’utilitaria più venduta in Europa (e Fiat si disputa con Volkswagen il primato sul mercato continentale); l’M24 prodotto dalla Olivetti era il primo personal computer nelle vendite su scala mondiale; gli abiti firmati da stilisti italiani come Armani e Valentino dominavano nelle vetrine delle boutique della 5th Avenue di New York. Non solo: era in atto l’ascesa della «terza Italia» dei distretti industriali, che avrebbe dato slancio a territori i quali parevano ai margini dello sviluppo produttivo, suscitando un interesse tale da indurre la Productivity Commission del Massachusetts Institute of Technology a farne oggetto di casi di studio.
Quei successi si reggevano su un’impalcatura precaria, che non poteva mantenersi a lungo. Chi allora si spinse addirittura a parlare di un «nuovo Rinascimento italiano», contrapponendo i luminosi anni Ottanta agli oscuri Settanta, tralasciava il fatto che i problemi precedenti erano stati archiviati, non risolti. Il boom che l’Italia sembrò conoscere fra il 1985 e il 1990 sfruttava un insieme di opportunità congiunturali che rendeva la crescita soltanto temporanea. Per prolungarla si sarebbe dovuto mettere mano ad alcuni nodi strutturali che invece la politica si guardò bene dall’affrontare. Per giunta, si trascurava che, con l’ingresso nel Sistema Monetario Europeo, il Paese si era avviato lungo una strada che prevedeva delle tappe obbligate su cui non si era fatta sufficiente chiarezza. In questo senso, l’europeismo era tutt’altro che una soluzione priva di costi e indolore per i costumi di una compagine sociale convinta di poter procedere a modo suo, con scarsa trasparenza, lungimiranza e senso di responsabilità.
Eppure, lo aveva posto in evidenza con notevole preveggenza Paolo Baffi, grande economista formatosi alla Bocconi e all’epoca governatore di Bankitalia, durante il dibattito sull’adesione dell’Italia allo SME. Baffi non poteva certo essere tacciato di antieuropeismo per le sue convinzioni, i suoi studi, la curvatura internazionale che aveva sempre caratterizzato le sue attività. Non di meno aveva ben presenti i rischi di un processo di convergenza monetaria per una nazione come l’Italia che non rientrava nel grappolo dei Paesi economicamente più solidi. Così nel 1978, in coordinamento con il ministero del Tesoro, negoziò per la lira una banda di oscillazione del 6 per cento, superiore a quella delle valute degli altri Stati, che si collocava al 2,25. Fu un risultato che garantiva all’Italia un margine di flessibilità, ma che procurò non poche amarezze al governatore della Banca d’Italia, al quale fu rimproverato, anche da amici e sodali, uno scarso europeismo, come se avesse voluto frenare il processo d’integrazione.
Non era quello l’intendimento di Baffi, il quale era preoccupato soprattutto delle asimmetrie fra le dinamiche dei vari sistemi economici. Forte di comparazioni e riferimenti storici temeva, come scrisse poco prima di morire, che «il giogo di un ordine guidato da una moneta dura come il marco, collocandosi entro fasce di oscillazione sempre più strette o nulle», non si addicesse a economie situate a differenti gradi di maturazione. L’Italia doveva aver cura di stare ben agganciata all’Europa, ma salvaguardando la propria autonomia di movimento, così da non appesantire di oneri troppo gravosi la sua economia reale.
In ogni caso, i ceti dirigenti che avevano voluto il processo di convergenza verso l’unificazione monetaria dovevano essere ben consapevoli che, una volta compiuto il passo decisivo verso l’introduzione di un vincolo esterno, erano richiesti comportamenti rigorosi, da cui diventava difficile e rischioso deflettere. Non si può dire, invece, che chi ha governato l’Italia dopo lo SME, dopo Maastricht e, soprattutto, dopo la nascita dell’euro, abbia agito complessivamente con il senso di responsabilità necessario.
Al contrario, la Bocconi interiorizza fino in fondo la convinzione che il movimento verso l’internazionalizzazione sia un percorso che non prevede ritorni all’indietro. Deve procedere per gradi, certamente, ma spostando sempre più in là i propri obiettivi, rendendoli più ambiziosi, cambiando il proprio modo di operare. Il suo scopo diventa quello di amalgamarsi sempre di più con un circuito di istituzioni di alta formazione che si muovono dichiaratamente in una logica sovranazionale. Le implicazioni di questo discorso sarebbero divenute del tutto esplicite con il proseguimento dell’assunto internazionalista, che conduceva direttamente ad ampliare la base di reclutamento degli studenti estendendola oltre i confini italiani. La presenza di studenti stranieri non doveva perciò costituire un fatto sporadico, ma strutturale. Allo stesso modo, l’apertura internazionale doveva sfociare nell’allargamento del corpo docente con l’inclusione di studiosi non solo formatisi all’estero ma con passaporto non italiano.
Una situazione complessa dalle radici lontane
Quando l’espansione (ma forse si potrebbe dire la creazione) di un modello Bocconi sempre più autonomo rispetto al ceppo dell’università italiana era iniziata cinquant’anni prima, in una società piena di aspettative positive sul proprio futuro, questi sviluppi, pur limitati al campo universitario, erano largamente imprevedibili. All’epoca, in merito alla costruzione europea, prevalevano le aspettative rispetto alle direttrici concrete. Si discuteva mentre ancora dominavano la divisione del mondo in due blocchi contrapposti e l’Asia non era ancora ascesa al rango di protagonista sullo scacchiere internazionale. L’Italia aveva partecipato dall’inizio al disegno europeo, ma nella logica atlantica. Invece giunse al trattato di Maastricht in concomitanza con lo sfaldamento dell’impero sovietico, mentre si stava per compiere il balzo verso il nuovo scenario della globalizzazione.
Alla fine degli anni Sessanta si era manifestato anche, come stimolo all’integrazione continentale, il tema della «sfida americana» (sollevato da Jean-Jacques Servan-Schreiber nel 1967 con il libro che in Italia aveva trovato l’avallo di Ugo La Malfa e di Gianni Agnelli), ma si trattava pur sempre di una competizione all’interno dei valori e delle esperienze del mondo occidentale, nel presupposto che da quella gara quest’ultimo non potesse uscire che migliorato. Unificazione europea e leadership occidentale degli Stati Uniti non erano certo dimensioni in contrasto, ma interagenti, in un ordine internazionale ancora dominato da Bretton Woods e gli elementi di frizione venivano riportati tutt’al più al gollismo.
Il cambiamento globale avvenuto nel corso dell’ultimo mezzo secolo ha messo in gioco tutti i presupposti di allora, moltiplicando le tensioni politiche ed economiche, sempre più strettamente intrecciate all’avvento della globalizzazione, fino a far saltare regole che sembravano create per disciplinare indefinitamente il mondo. Inevitabile che da una simile alterazione dello scacchiere internazionale e delle forze in gioco sia venuta una ridislocazione che ha redistribuito gerarchie e posizioni, scompaginando le classifiche. Essa ha anche riassegnato i ruoli dei vincenti e degli sconfitti. L’Italia è uscita danneggiata più di altri soggetti perché se, com’era del resto scontato, ha perso la percezione che nutriva allora di se stessa, non ne ha fin qui riformulata un’altra. Di qui lo stato di smarrimento che è subentrato e che riesce arduo superare.
A giudicare le cose dall’angolatura specifica della Bocconi, molti progressi paiono raggiunti e stabilizzati. Oggi i suoi studenti, come i suoi docenti, interagiscono assiduamente con università e istituzioni formative che qualche decennio fa rappresentavano più che altro termini di raffronto ideali. Gli sforzi compiuti non solo e non tanto per avvicinare la Bocconi a esse, ma per ordire una trama comune di scambi e di relazioni, hanno indubbiamente avuto successo. Lo testimonia lo stesso bilinguismo che si è ormai stabilito (con gli studenti che non di rado scrivono in un inglese migliore dell’italiano…). E non c’è dubbio che l’internazionalizzazione e l’europeizzazione della Bocconi si siano riflesse anche sull’attuale condizione di Milano, che ha tratto spinta anche dall’apertura sovranazionale dell’Università, alla quale ha altresì dato alimento. D’altronde la Bocconi, imperniata com’è sull’insegnamento di discipline che sono tra le più anglofone, non poteva che favorire un processo di assimilazione linguistica che ha accentuato l’inclinazione multiculturale della città. Non c’è dubbio che fra università e metropoli ci sia stata un’interazione efficace che ha funzionato bene soprattutto per quanto riguarda la proiezione internazionale, ora punto di forza condiviso dalla città e dai suoi atenei. Un successo locale e internazionale importante però conseguito a discapito di un sistema nazionale che rischia di vedersene escludere.
Nessuna riflessione di lungo periodo sulla funzione dell’università, sia pure di un’università così speciale come la Bocconi, può prescindere dal suo rapporto con la realtà e la storia della nazione, come spiegava assai bene Pasquale Villari in un saggio magistrale come «Di chi è la colpa?», scritto all’indomani della terza guerra d’indipendenza, vinta sì dall’Italia al tavolo della pace, ma perduta sui campi di battaglia, con due sconfitte disastrose come quelle di Custoza e di Lissa. Villari sottolineava acutamente il difetto di costruzione che il nuovo Regno d’Italia mostrava fin dalle origini, rivelando un amalgama non riuscito, un impasto privo della necessaria capacità di tenuta.
Nei centocinquant’anni buoni che sono passati dalla pubblicazione (avvenuta sul Politecnico di Carlo Cattaneo) della prima edizione del saggio di Villari, i divari interni all’Italia non solo non si sono ricomposti, ma per certi versi si stanno allargando. Si pensi, naturalmente, al più noto, quello fra il Nord e il Sud, che si è esteso ulteriormente nell’ultimo decennio (un problema testimoniato anche dall’afflusso di studenti meridionali a Milano: non perché scelgano di compiere gli studi presso le grandi università settentrionali, ma perché scorgono in questo una via d’uscita dalle scarne opportunità di futuro offerte dai loro luoghi d’origine).
L’Italia post-unitaria in cui scriveva Villari era una società a macchia di leopardo dove troppo poche isole concentrate di attività moderne erano assediate da un universo di arretratezza molto vasto, che ne sopiva gli influssi e gli impulsi al dinamismo. L’Italia contemporanea è più omogenea di quella di allora soltanto in apparenza; perché a guardarla in controluce risaltano le differenze, le disparità, le contraddizioni che non le consentono di agire come un organismo unitario, proprio come avveniva già nell’Ottocento. Adesso come allora le forze che esprimono un potenziale di innovazione non dispongono di un vigore sufficiente per orientare il Paese.
Ai tempi di Villari, come in seguito, la strada per la crescita dell’Italia è stata cercata attraverso il confronto con le nazioni straniere, in parte per apprenderne la lezione, in parte per dare forma a un proprio modello di sviluppo. Nell’epoca del multipolarismo susseguita al secondo conflitto mondiale, l’Italia si è incuneata, all’ombra dell’atlantismo, nel concerto occidentale, trovandovi per un verso una traccia già delineata da seguire, per l’altro un alveo di contenimento delle spinte centrifughe che si sono sempre manifestate sul suo cammino. Venuto meno l’ordine della guerra fredda, i ceti dirigenti indirizzano la nazione verso la costruzione e la disciplina europee, pensando che potesse trovarvi la bussola che le mancava. Una strategia che funziona fino alla crisi di quest’inizio secolo, quando l’Italia scopre progressivamente il proprio disagio ad affidarsi alla regolazione dell’Unione. Da ultimo, reagisce all’incertezza delle prospettive europee credendo di riscoprire in se stessa, nell’attenzione e nell’ascolto dei bisogni elementari della società interna, il modo per sbloccare un Paese in stallo. Sennonché, questa svolta va in direzione opposta a quella che hanno sempre indicato i nuclei che l’hanno pilotata guardando alla scena internazionale, si trattasse di alleanze politico-diplomatiche, sviluppo civile e culturale, diffusione delle relazioni di mercato. Solo il fascismo, e anch’esso solo in maniera molto parziale, pensava che il futuro dell’Italia potesse essere assicurato semplicemente dalle sue risorse interne, senza lavorare sulla sfera internazionale.
Il pericolo di una lacerazione è altissimo. Tanto più che nel mare della politica si agitano richieste in contrasto le une con le altre. Come si può domandare l’autonomia per le regioni settentrionali quando, per contro, si pretende di mobilitare le risorse su temi unificanti del welfare da applicarsi con uniformità sul territorio nazionale? Ancora: lo sviluppo italiano si è verificato sull’onda dei cicli di espansione internazionale quando ha saputo coglierne spazi e opportunità. Oggi un ripiegamento non farebbe che accelerare la tendenza al declino.
Per un’istituzione formativa come la Bocconi, la partita dei prossimi anni appare oltremodo complicata. È chiaro che l’Università non può che mantenere e rafforzare la posizione che ha raggiunto, quella dell’avamposto di un circuito universitario internazionale di cui è un anello riconosciuto.
L’ateneo milanese continuerà quindi a svolgere l’opera per cui si è preparato, raccogliendo studenti e docenti da tutto il mondo e chiedendo loro un impegno continuo per l’innalzamento della qualità degli studi, dell’insegnamento e della ricerca. Ma può assolvere a questo compito in modalità e con atteggiamenti diversi. O con l’orgoglioso senso di autonomia di un’istituzione di rango, che bada solo ed esclusivamente a curare al meglio la preparazione dei giovani che deve istruire, operando in una sorta di distacco rispetto alla realtà del Paese in cui è sorta. Oppure, e questa può diventare la sfida più impegnativa, farlo senza perdere di vista il retroterra di una nazione che deve recuperare una visione del suo futuro e del suo posto nel mondo.
Ma allora non può trascurare il dialogo con una società italiana che ora sembra esprimere una preferenza per valori e comportamenti dissonanti rispetto a quelli posti dalla Bocconi in cima alla propria scala. Europeismo e internazionalismo appartengono comunque al patrimonio di cultura e di civiltà di quel Nord che fa capo a Milano e sono ormai un dato della realtà vissuta da chi vi risiede. Per questo occorre riattivare la circolazione dei modelli e delle idee all’interno del Paese: affinché il suo tessuto vitale non si sclerotizzi (un rischio che corre anche a causa dell’invecchiamento della popolazione).
Del resto, non è forse nelle corde della Bocconi recuperare il meglio dell’esperienza italiana per trasferirlo ai circuiti della circolazione globale della cultura?

-
Dalla contestazione al crollo del muro di Berlino
-
Verso il 2000 e oltre
-
Verso la teaching and research university
-
SDA, la formazione post-esperienza
-
Un universo complesso e sempre in divenire